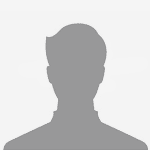
Contenuti per adulti
Questo testo contiene in toto o in parte contenuti per adulti ed è pertanto è riservato a lettori che accettano di leggerli.
Lo staff declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che si potrebbero sentire offesi o la cui sensibilità potrebbe essere urtata.
“Elogio della vergogna (perduta): guida polemica al ritorno del buon gusto”
Capitolo 1 – La vergogna, questa sconosciuta: un sentimento antico, un freno prezioso
C’è stato un tempo – non così remoto come molti credono – in cui la vergogna era considerata una componente fondamentale del comportamento umano. Non una gabbia, non una ragnatela repressiva, ma un elegante sistema immunitario interiore, capace di proteggere il vivere civile da eccessi, ridicolaggini e malcostume. Si poteva arrossire per una parola di troppo, un gesto rude, un abito fuori luogo. E quell’imbarazzo non veniva percepito come debolezza, ma come segno di sensibilità e intelligenza emotiva.
Dai Greci, che con l’“aid?s” celebravano il freno etico della convivenza sociale, ai Romani, che distinguevano tra il “pudor” (segno di nobiltà interiore) e il “turpis” (la vergogna sociale ben meritata), il senso del decoro aveva una sua dignità. Persino nel Medioevo, epoca di estasi religiose e pubbliche penitenze, chi si esponeva troppo era additato, e non in senso positivo. Il Rinascimento pullulava di uomini completamente assorbiti dalla loro “reputazione”, parola oggi divenuta sinonimo di “mi piace” su un social.
Oggi? Oggi è vietato suggerire che qualcuno dovrebbe provare vergogna. Si diventa immediatamente “giudicanti”, frustrati, repressivi”. Come se il buon gusto fosse una patologia da curare e non un valore da insegnare. Abbiamo sostituito il pudore con l’esibizionismo, il decoro con la sfrontatezza. E così siamo finiti in un’epoca dove tutto si mostra, nulla si filtra, e ogni idiozia viene celebrata come "spontaneità". Ma essere spontanei non significa essere molesti, sciatti o ridicoli. Significa essere autentici, con la misura che ci fa umani.
Ecco perché oggi sentiamo, più che mai, la mancanza della vergogna: quel piccolo imbarazzo sano, quella voce interiore che un tempo ci faceva dire: “No, questo non lo faccio. Non mi espongo così. Non sono cretino fino a questo punto.”
Benvenuti nel pamphlet della nostalgia civica. Ironico, sì. Polemico, anche di più. Necessario? Direi disperatamente sì.
Capitolo 2 – Social Media: il palcoscenico di chi ha perso il senso del ridicolo (con menzione speciale agli over 55)
Che i social media siano il loggione del teatro mondiale degli svergognati lo sapevamo. Ma il colpo di scena più sorprendente è stato vedere come la generazione dei cinquantenni – quella che ieri criticava i giovani per l’uso smodato del telefono – oggi abbia invaso Facebook, Instagram e perfino TikTok con una spavalderia visiva da far impallidire qualsiasi adolescente in crisi ormonale.
Stiamo parlando dell’invasione giornaliera di foto di cappuccini con cuoricini, citazioni moraleggianti scritte in Comic Sans, e faccioni ravvicinati con filtri “rosa tramonto” e sguardo da boccale di Lambrusco. Signore over 60 riprese in trionfo mentre sfornano torte “low-carb” o fanno yoga alle 6 del mattino in tuta leopardata. Uomini barbuti da pensione che postano selfie in palestra come se stessero partecipando a “Uomini e Donne – Operazione Ritorno”.
Ma attenzione: guai a pensare che siano autoironici. Il problema è tutto lì. Questi post sono tragicamente seri. Con didascalie del tipo:
> “Mi godo l’energia dell’universo mentre sorseggio il mio cappuccino ??”
Ogni like ricevuto è una conferma della propria (presunta) genialità. Ogni reaction un applauso all’ego in pigiama. E la vergogna? Non pervenuta. Nessun controllo di qualità visivo, nessuna revisione testuale, nemmeno il dubbio sull'opportunità del contenuto.
Un tempo, chi diceva sciocchezze al bar lo faceva davanti a 4 persone. Ora, lo stesso individuo può distribuire nonsense poetico a 400 amici virtuali, inondandoli ogni mattina con cuori, stelle e gif anime. Dietro ogni click, dietro ogni post inutilmente epico, c’è l’eco di una vergogna uccisa da un hashtag.
Capitolo 3 – L’era del selfie imbarazzante: linguacce, bocche a papera e facce da ebeti
Il selfie, almeno agli inizi, sembrava una simpatica trovata tecnologica: immortalarsi nei momenti di gioia, portare con sé un ricordo. In fondo, ci stava. Peccato però che, come ogni cattiva abitudine diventata moda, si sia trasformato in un’allucinazione collettiva di volgarità iconografica.
Adesso il selfie è un’arma. Puntata verso il mondo. Un gesto di conquista, un rituale puramente narcisistico che non punta a ricordare noi stessi in un contesto, ma a metterci sempre al centro – trionfanti – del nulla cosmico. Non importa dove sei: a Versailles o alla fermata del bus. Ciò che conta è che si veda bene la tua lingua fuori.
Ecco, l’estetica della bocca a papera ha travolto intere generazioni. Non solo sedicenni in crisi: oggi persino professori universitari e madri 45enni si auto-ridicolizzano sui social, facendo faccine studiate, sorrisi plastificati e smorfie goliardiche da festival del disagio.
La questione non è che si fanno selfie. Il problema – diciamolo – è che ci si mette in pose da idioti e ci si aspetta anche l’approvazione pubblica.
Non esiste più il pudore del volto sereno. Ora o sei buffo, o sei poco “engage”.
E guai a far notare che sembrano dementi: sei tu il “noioso”, l’“antico”, il “frustrato”.
Zoommate bene, fatevi vedere. Tanto di arrossire non ve ne frega più nulla.
Capitolo 4 – Viva voce e zero cervello: telefonisti da circo nei luoghi pubblici
Una volta, rispondere al telefono in pubblico comportava discrezione. Si copriva la bocca con la mano, si cercava un angolo, ci si scusava sottovoce. Ora invece pare che la conversazione sia diventata uno spettacolo teatrale, e tu – povero malcapitato – spettatore non pagante, devi sorbirti il monologo di gente che non conosci, su dettagli che non ti riguardano, con un vocione da venditore ambulante in saldi.
“PRONTOOO? MA SÌ, È PER IL CERTIFICATO DELL’ORTOPEDICO! QUELLO DI MIO FRATELLO, QUELLO CHE HA LA PANCIA!”
E giù a raccontare radiografie, faide familiari e mal di stomaco, mentre tu, lì accanto, tenti di leggere un giornale o semplicemente di vivere in pace la tua colazione. Ma la privacy, cos’è? Una curiosità borghese anni ‘50. Nel 2025, ogni parola detta in viva voce è un diritto umano.
Il tragico è che spesso le persone parlano col telefono appoggiato sul tavolo, urlando verso il microfono come se stessero partecipando a un incontro ONU a distanza. La voce del parente/amico/coniuge/grillino (immancabile) esce in altoparlante con volume da stadio. Tutti ascoltano. Nessuno vuole, ma tutti devono. È l’audioviolenza quotidiana.
E se osi lanciare uno sguardo appena disapprovante, ti becchi pure l’occhiata da martire: “Scusa, ho diritto di parlare…”.
Il problema non è che parli, ma che lo fai come se fossi solo al mondo.
Vecchia cara vergogna, se ci sei, batti un colpo. Ma temo sia stata messa in modalità “silenzioso”.
Capitolo 5 – Musica a tutto volume e serie TV al bar: condividere l’idiozia anche con gli sconosciuti
Ci siamo abituati. Ormai la musica a tutto volume che esce da uno smartphone in autobus è come il rumore delle gomme sull’asfalto: fa parte del paesaggio urbano. Ma chi l’ha detto che dobbiamo sopportarlo in silenzio? Chi ha deciso che tu, seduto di fianco a uno zombie col telefono in mano, devi sorbirti l’ultimo disco trap o peggio, un episodio di “Terra Amara” visto su YouTube senza cuffie?
Non stai in un cinema, né in una discoteca. Sei su una panchina. In treno. In biblioteca. Eppure ormai *il silenzio è trasgressione, non l’eccesso.*
Prova a leggere un libro, e ti arriverà nelle orecchie una colonna sonora scelta da un tizio con gusto musicale fermo alle recite dell’asilo. Musiche trap sature di auto-tune. Battiti martellanti, accompagnati da testi creati da generatori automatici di idiozie.
E vuoi mettere chi guarda le serie TV sul telefono senza auricolari? Un’esperienza cinematografica imposta a forza, dove il finale di stagione di una soap turca si fonde con l’indecenza assoluta del “tutti devono partecipare alla mia esperienza audiovisiva.”
Che poi, puntualmente, interrompono ogni due minuti per rispondere:
– “MA GUARDA CHE C’È ANCORA LA PUBBLICITÀ, ASPETTA!”
E tutto questo, naturalmente, in ambienti frequentati da altri esseri umani con padiglioni auricolari ancora funzionanti.
Una volta si diceva: “De gustibus non disputandum est”. Oggi si dice: “Tutti devono subirli.” Non più la libertà di ascoltare, ma l’obbligo di sopportare.
E la vergogna? Ah, quella è rimasta dentro gli auricolari. Che, purtroppo, nessuno usa più.
Capitolo 6 – Urlare: l’unico tono ammesso nel vocabolario moderno
Se l’uomo del passato parlava con tono pacato, oggi per esistere bisogna strillare. In qualsiasi contesto. Dal baretto sotto casa al supermercato, dal treno al corridoio dell’ospedale. “MA TI HO DETTO CHE IL MIO ENSALATIERA È FINITO IN LAVATRICE!” – urla una, mentre tu cerchi di morire in pace in fila dal medico.
Non sono solo maleducati, sono convinti di essere divertenti.
Parlano come se stessero in uno studio televisivo davanti a una platea di amici immaginari. Sputacchiano sillabe, ridono sguaiati, infilano parolacce ogni tre parole “così suona più naturale”. Il vocabolario è composto per il 70% da intercalari tipo:
> “Cioè fighissimo”,
> “Giuro che morivo”,
> “Oddio zia, te lo giuro sul pane!”
Tutto accompagnato da una gestualità rumorosa, vocioni da scimmia eccitata e una totale indifferenza al contesto. Non importa se ti trovano in treno, a un funerale, in una chiesa, in una biblioteca, o mentre stai cercando di concentrarti nel tuo unico momento di silenzio: i nuovi italiani “parlano alto”, punto.
Eppure, una volta la gente faceva lo sforzo di moderare voce e vocaboli in base a dove si trovava. Esisteva una cortesia acustica, un senso del pudore uditivo.
Ora tutto è confuso: tono da stadio, contenuti da bar, gesti da cortile e zero autocoscienza.
La vergogna è morta. Ma l'eco dei suoi assassini si sente ovunque.
Capitolo 7 – “Era meglio quando c’era lui…”: il ritorno impunito dei nostalgici del Ventennio
C’era un’epoca in cui dire di essere fascisti causava almeno qualche attimo di imbarazzo. Se non davanti agli altri, almeno davanti allo specchio. Oggi invece c’è gente che lo rivendica con orgoglio tra un caffè e una sigaretta, come se stesse parlando del proprio piatto preferito.
“Eh, io sono fascista. E allora?” – pronunciato con la stessa naturalezza con cui si dice: “Piace il ragù alla bolognese”.
Sui social pullulano citazioni fuori contesto di Benito Mussolini (quando va bene), rabbiose invettive contro la democrazia, e frasi da baretto tipo:
> “Almeno lui faceva funzionare i treni!”
Come se la puntualità delle Ferrovie fosse motivo sufficiente per giustificare la censura, l’olio di ricino e le leggi razziali.
Non si tratta solo di ignoranza storica – perché ce n’è, e tanta – ma di un’esibizione impudica di quella che un tempo era considerata una vergogna. Dire “sono fascista” oggi fa curriculum tra alcune compagnie e gruppi Facebook dove la grammatica è optional e la storia mai letta.
E il punto chiave è proprio questo: non se ne vergognano. Anzi. La dichiarazione ha il tono della provocazione compiaciuta.
Ti sfidano con lo sguardo da “adesso cosa mi dici?”. E quando glielo dici – provi a spiegare, citare, ragionare – ti beccano con il solito binomio: “sinistroide radical chic”.
Intanto la parola fascismo viene normalizzata, banalizzata, riciclata come fosse una semplice interpretazione del mondo e non come un’autostrada verso la prepotenza e la disumanizzazione.
E dobbiamo accettare questo scempio, sorridere, tollerare, perché tutto è “opinione”. Anche la nostalgia del totalitarismo.
Ma il punto è questo: non tutto ciò che si può dire, andrebbe detto. E non ogni pensiero merita una piattaforma. Alcuni dovrebbero rimanere sepolti nelle ombre della decenza.
Il fatto che nessuno arrossisca più nel pronunciare certe idee oscene… ci dovrebbe far vergognare. Tutti.
Capitolo 8 – Razzismo, misoginia e omofobia: la nuova “sincerità” senza filtri
Un altro trionfo dell’epoca postvergognosa: la rivendicazione orgogliosa del pregiudizio.
Non bastava l’ignoranza. No. Ora si è trovato il modo di imbellettarla con parole tipo “parlare chiaro”, “dire le cose come stanno”, “essere sinceri”.
E così, la frase tipica diventa:
> “Io non sono razzista, ma…”
Segue un concentrato di fango verbale degno del peggior dopoguerra. Gli immigrati “ci rubano tutto”, i gay “facciano quello che vogliono ma lontano da me”, le donne “vittimismo continuo” e via di questo passo, con una leggerezza da aperitivo.
Poi ci sono i leoni da social, che parlano di “decadenza della civiltà” vedendo una pubblicità con una coppia omosessuale, o gridano allo scandalo se una donna si presenta a condurre un talk show senza decolleté a vista.
Ma attenzione, loro non sono sessisti. Sono “amanti del buon gusto”.
Il razzismo? “Solo un’osservazione demografica”. L’omofobia? “Solo preoccupazione per i bambini”.
Tutti maestri di cerimonie del pregiudizio normalizzato, insistono su un diritto che nessuno ha mai negato loro: quello di sembrare degli imbecilli. Il punto è che ora non se ne vergognano più. Prima lo si diceva in privato, con tono basso e lo sguardo nervoso. Oggi lo si urla in un video TikTok tra una risata e un “libertà di pensiero, fratè”.
E il silenzio generale che li circonda? Un tempo avremmo reagito, indignati. Oggi si gira la testa. Si dice: “Eh vabbè, è uno che dice quel che pensa”.
Ma non tutto ciò che pensi ha diritto di danneggiare gli altri. Il confine tra opinione e offesa è stato polverizzato. Insieme alla vergogna.
O forse la vergogna esiste ancora. Ma è finita non nei colpevoli… bensì nei silenziosi che non reagiscono più.
Capitolo 9 – L’eterno giovanile: sessantenni con outfit da TikToker dodicenne
Certo, l’età è solo un numero. Ma il senso del ridicolo è un’altra cosa. E pare che molti abbiano perso completamente il contatto con questa nobile facoltà umana.
È il caso di quei sessantenni – spesso padri di figli ormai adulti che vivono ancora in casa – che decidono di ringiovanire radicalmente, almeno esteticamente. E allora via di jeans strappati, t-shirt con scritte in slang inglese (che nemmeno capiscono), scarpe fluorescenti da skateboarder e occhiali da sole a specchio in pieno inverno.
Ti domandi: vanno a fare un TikTok o a un raduno di adolescenti alternativi? No: stanno andando a fare la spesa. O dal commercialista. Ma con il cappello da rapper e il gilet imbottito modello “trap della terza età”.
Il loro corpo dice “pensione”, la loro estetica grida “Milano Fashion Week (post-sbronza)”.
E badate bene: non c'è autoironia. Non c'è voglia di scherzare. C'è convinzione. Volontà di rientrare nel giro. Di risultare “fichi”, “frizzanti”, “giocosi”.
Tutto lecibile, per carità. La libertà di vestirsi come si vuole la garantiamo a chiunque… tranne a chi pretende di essere applaudito per il proprio cattivo gusto.
Un conto è non piegarsi alla tristezza del grigio perla. Un altro è ostinarsi a vestirsi come il proprio nipote, credendo di passare per guida spirituale. Ma passando, invece, per carnevalata urbana.
Questi eterni Peter Pan urbani confondono giovinezza con infantilismo egocentrico. Non si vestono come si sentono. Si vestono per apparire, per compiacere un’immagine stereotipata di gioventù che nessun giovane ha mai chiesto.
E la cosa più imbarazzante è che si vantano della loro “originalità”. Quando invece appaiono solo incapaci di accettare il tempo che passa.
Una società che non accetta di invecchiare è una società che non crede nella bellezza del cambiamento. E chi non ha più il senso di vergogna nel travestirsi da quello che non è... perde anche il senso della propria identità.
Capitolo 10 – I giovani vestiti da vecchi e i vecchi vestiti da ragazzini: il festival del disorientamento estetico
Una volta l’età si accettava, con un po’ di grazia e, sì, con modestia. Si cercava di essere coerenti con la propria stagione della vita: i ragazzi si vestivano da ragazzi, gli adulti da adulti, e i nonni con la decente sobrietà dei loro anni. Oggi? È il caos. È l’anarchia del guardaroba. È il carnevale costante e sgraziato della modernità che ha perso l’ultima bussola: quella del buon senso estetico.
Oggi incontri ventenni che sembrano contabili in pensione: pantaloni larghi da nonno in gita termale, mocassini lucidi, maglioncini pastello, camicie abbottonate fino al collo senza cravatta – perché “fa vintage ironico”, dicono loro. Ma più che vintage sembrano pronti per l’elezione del rappresentante di scala nel condominio di una casa di riposo.
Nel frattempo, i sessantenni si presentano con jeans a taglio basso, felpe oversize “Supreme” tarocche, e scarpe dai colori che nemmeno un evidenziatore umano oserebbe indossare.
E mentre i giovani sembrano usciti da un raduno Inps, i boomers sfilano con disinvoltura a metà tra lo skater e il DJ balneare.
Il risultato? Un mondo visivamente sconclusionato, dove nessuno appare com’è. L’età diventa una finzione continua, recitata attraverso outfit presi da Instagram, scelti non per sentirsi se stessi, ma per ottenere like, occhiate, o semplicemente per confondere il prossimo.
Non è questione di moda. È perdita totale di identità e soprattutto di decoro.
E se qualcuno osi dire: “Forse sembri un po’ ridicolo così”, la reazione è immediata:
> “Mi esprimo come voglio! Sei solo invidioso!”
Eh già. Perché oggi anche l’imbarazzo è censurato, visto come un’antica superstizione.
Ma vestirsi fuori tempo non è un atto di libertà. È ignorare che esiste un momento per ogni cosa. E anche un’età per ogni taglio di pantalone.
Un consiglio? Osservatevi una volta allo specchio. E chiedetevi: “Se mi vedessi per strada vestito così, riderei?”
Ecco. È lì che, forse, riemerge il barlume della vergogna. Usatelo.
Capitolo 11 – Vacanze con mamma e papà a 34 anni... ma con foto “esistenziali” da intellettuale introverso
C’è una tipologia umana che negli ultimi anni ha preso il sopravvento. Sono adulti, manager a progetto o eterni fuorisede, che a trent’anni suonati passano ancora le vacanze d’agosto con i genitori nella stessa località balneare dal 1997. Dormono nella cameretta con le tende di Winnie the Pooh e si svegliano col profumo del Bimby materno. Ma attenzione: esteticamente non si presentano come mammoloni. No. Sono degli “spiriti liberi”. Artisti. Anime pensose.
E così, mentre papà stende l’asciugamano e mamma taglia la frutta sotto l’ombrellone, loro si mettono in posa sulla scogliera, sguardo perso all’orizzonte, libro ben visibile in mano (magari Pessoa, ma senza aver superato pagina 12).
Postano su Instagram scrivendo:
> “Ho lasciato che il silenzio mi parlasse. #Rinascita #SoulSearching”
O ancora:
> “In fuga dal rumore del mondo. #DeepVibes #LunaEMare”
Ma in realtà il giorno dopo saranno alla Coop con la madre, discutendo se prendere il pesto con aglio o senza, e se lavare a mano il costume, perché “ha la retina sensibile”.
Quello che fa ridere, o meglio piangere, è la totale incapacità di ammettere la cosa: nessuno vuole dire “sono andato in vacanza con i miei perché non ho né soldi né voglia di organizzarmi da solo.”
No. Devono costruire l’illusione della “scelta consapevole”, della “ricerca interiore”.
La realtà però è evidente: si è passato dai viaggi dell’anima ai viaggi organizzati da mamma.
E la vergogna? Che fine ha fatto l’antico rossore davanti all’idea di sembrare eternamente dipendenti, eternamente bambini? Dispersa – ancora una volta – sotto chili di filtri fotografici e citazioni saccheggiate da Bukowski (che peraltro li avrebbe presi a schiaffi).
Non è il fatto di andare in vacanza con i genitori. È l’ipocrisia dell’estetica “profonda” fatta per nascondere quanto poco si voglia crescere.
Fatevene una ragione. E magari, la prossima volta… anche un piccolo esame di coscienza. In silenzio. Senza hashtag.
Capitolo 12 – Conclusione: Torniamo a vergognarci, che è il primo passo per tornare civili
Se questo pamphlet ha un tono aspramente ironico, un po’ crudele e parecchio esasperato, è perché ci troviamo in un’epoca che ha smarrito completamente il senso del limite. Non del proibizionismo, della censura, del controllo ossessivo dei comportamenti. Ma del limite sano, morale, estetico e umano, che un tempo si incarnava in una parola semplice quanto potente: vergogna.
Non c’è più. È stata dismessa come se fosse un fastidio arcaico, una catena imposta da chissà quali moralismi perbenisti.
E invece no. La vergogna non era il problema. Era la soluzione. Era quel filtro interiore che ci salvava dall’esporsi troppo, dal dire troppo, dal mostrare parti di noi che era meglio tenere per sé. Forse non per sempre. Ma almeno non in pubblico.
Oggi il mondo è un immenso palcoscenico senza registi. Tutti parlano, tutti si mostrano, tutti esibiscono ogni pensiero, ogni parte del corpo, ogni presunta opinione come se il pubblico dovesse ringraziare. Ma nessuno si chiede: “Sto disturbando? Sto esagerando? Sto facendo la figura del deficiente?”
Risposta: molto spesso sì.
E allora, mentre il mondo si riempie di urlatori egocentrici, voyeur digitali, adulti immaturi, adolescenti con barba e over 60 con cappellino da baseball al contrario, la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare è questa: reimparare a provare un po' di vergogna.
Vergogna quando si dice un’idiozia.
Vergogna quando si invade lo spazio altrui.
Vergogna quando si ostenta volgarità, ignoranza o infantilismo come se fosse uno stile di vita.
Non per reprimersi, ma per riconoscere che non tutto va esposto, detto, condiviso, insultato o ballato in pubblico.
Vergogna buona, costruttiva, discreta. Che magari non ci farà più like, ma ci farà essere – per una volta – un pochino più umani.