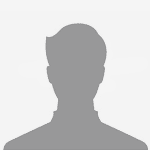01-Note dell’autore: introduzione.
Mi chiamo Abramo “Telonious” Monk e non so perchè mi sono messo qui a scrivere.
Cioè, diciamo che non riesco a capire del tutto perchè ve la voglio raccontare questa storia. Non so nemmeno se ci sarà qualcuno a cui la cosa potrà interessare e, ammesso che questo qualcuno siate proprio voi, non sono affatto sicuro che riuscirò a convincervi della veridicità dei fatti.
Però penso che devo farlo, devo scrivere la storia di quei tizi, devo lasciar detto a qualcuno che sono esistiti, che hanno inseguito il proprio destino e poi, dopo tante meraviglie, sono spariti, volati via.
Forse semplicemente glielo devo a quei tre.
Perché erano speciali, specialissimi.
Davvero.
Di fianco a me, oltre la finestra, sta per addormentarsi un’altra estate. E’ la cinquantasettesima volta che glielo vedo fare.
Il silenzio copre ogni cosa grande e piccola penetrando ovunque, nelle case, sui prati, fin dentro le crepe dell’asfalto e la spessa corteccia di questi alberi ombrosi.
Così in tutto questo tacere mi sembra di sentirli ancora chiacchierare quei tre matti, seduti nel retro del mio locale, incuranti di tutto, le mani strette attorno alle lattine di birra ghiacciata e le dita chiuse sulle sigarette accese. Mi pare che parlino di qualcosa che solo loro hanno capito e che senza darlo a vedere nascondano ancora un segreto, una felicità o un tormento sconosciuto a tutti gli altri.
Faccio il barista da quando ho tredici anni e di storie strane ne ho sentite e viste succedere, credetemi, ma quello che hanno combinato quei tre le batte tutte, parola mia.
Mettetevi comodi perchè vi racconterò come sono andate davvero le cose.
02-Chi era Marcos Elveira.
Il primo di cui voglio parlarvi è Marcos, quello che credo sia il personaggio più complesso da capire a fondo.
Quando lo conobbi era un omone grande e grosso sulla trentina, capelli e occhi castani, un sorriso aperto e una palese inclinazione a reggere bene l’alcool. A quanto ne sapevo se la cavava facendo lavoretti qua e là.
Dopo qualche tempo che frequentava il mio bar mi raccontò di essere nato a Montevideo e che sin da piccolo si era dovuto abituare a dormire con un occhio solo.
Era cresciuto in mezzo alla strada come moltissimi bambini della sua età e aveva imparato dai ragazzi più grandi come si danno i pugni e da sua madre, donna Esmeralda, come si legge e si scrive.
Da suo padre non aveva imparato niente perché non lo aveva mai conosciuto.
Intorno agli otto, nove anni era solito girovagare con la sua banda di giovani delinquenti alla ricerca di qualche turista da derubare e mentre percorreva le vie della sua città alla ricerca di una vittima ripeteva le tabelline e l’alfabeto così che sua madre, una volta tornato a casa, non fosse scontenta di lui mentre facevano i compiti assieme.
-Tre per tre nove, – mi disse ridendo - e sfilavo un portafoglio ad un cinquantenne tedesco in bermuda e camicia hawayana. Sei per sei trentasei… e scippavo una vecchia americana venuta dal Minnesota con una compagnia di ex crocerossine. A-e-i-o-u … e fregavo un orologio dal bancone del negozio dei pegni all’angolo. Era una vera pacchia! Univo l’utile al dilettevole, capisci?-
Mi raccontò anche che la cosa andò avanti così per anni, finchè la polizia non beccò in flagrante il suo amico Pedro mentre cercava di rubare una moto. Dopo un paio di schiaffi Pedro descrisse al commissario una fila di crimini che lui e altri amici, Marcos compreso, avevano commesso negli ultimi sei mesi.
I gendarmi vennero a prenderlo con tanto di sirena e se lo portarono via lasciando sua madre a piangere sulla vecchia scala dai gradini di pietra.
Due anni di riformatorio gli insegnarono tante cose e fu nella penombra della sua cella che conobbe il proprio destino.
Dopo i primi mesi trascorsi nel penitenziario minorile fece domanda per lavorare così da poter mandare qualche soldo alla mamma della cui sorte si preoccupava tantissimo. Grazie alla sua buona condotta venne assegnato alla pulizia dei corridoi e dell’atrio ovest.
Poi si iscrisse alla palestra dell’istituto dove alzò pesi, saltò le parallele, si arrampicò lungo la fune e la pertica e, quando gli allenatori glielo consentirono, indossò casco e guantoni in brevi ma intensi combattimenti tra giovani detenuti. Il sapore del paradenti gli piacque subito.
Intanto, invogliato da un frate francescano che veniva in visita ai carcerati ogni giovedì, completò gli studi iniziati con la madre e iniziò a leggere i primi libri di
poesia, dapprima faticosamente poi con scioltezza sempre maggiore.
Sdraiato sulla minuscola brandina della sua cella si abituò giorno dopo giorno a scoprire il peso delle parole, l’efficacia che esse suscitavano nel descrivere il mondo, la forza che vi stava nascosta.
Lo incuriosivano sempre più tutte quelle strane definizioni, quei nomi altisonanti, quei verbi passati, presenti e futuri e ben presto seppe cogliere le infinite possibilità di aggregazione che tutti quegli elementi dimostravano di possedere.
Così mentre i suoi muscoli si ingrossavano all’interno delle sue braccia e del suo petto, il suo spirito si affinava, mostrandosi via via più sensibile e accorto.
Divenne forte e delicato assieme, attento e desideroso di vivere.
Questo per due lunghissimi anni.
Quando uscì dalla galera la prima cosa cosa che fece fu girarsi a guardare il grande portone di legno e sputare per terra. Non sarebbe mai più tornato lì dentro, mai più, a qualunque costo.
Quando arrivò a casa dalla madre le giurò che non avrebbe mai più rubato e che si sarebbe trovato un lavoro onesto.
Fece il lavavetri per mesi, scaricò migliaia di casse nei magazzini di ortofrutta del Mercato Comunale, vendette pesce e mais, cucì cinghie di cuoio per caschi da minatore, guidò i camion della nettezza urbana, frequentò un corso gratuito di poesia e letteratura, si iscrisse alla Biblioteca Nazionale e prese a frequentare la palestra del quartiere, “La casada”.
Fu lì che conobbe Santo, un vecchio atleta che tre decenni prima era divenuto famoso in tutto il paese come lottatore e che si era esibito un po’ ovunque, indossando un costume sgargiante, con il nome di El Enmascarado.
Santo aveva visto il mondo, era stato in Brasile, in Messico e persino negli Stati Uniti. Aveva avuto donne bionde, brune e rosse e persino posseduto una Buick azzurra. Santo aveva firmato contratti da migliaia di dollari, aveva bevuto champagne e dormito nei letti rotondi che stanno dentro i grattacieli del Nord America.
Ma sopratutto aveva lottato con rara maestrìa. Quando il wrestling non era ancora una moda e veniva considerato poco più di uno spettacolo da circo lui, El Enmascarado, aveva imparato a lottare, a cadere senza rompersi la schiena, a colpire l’avversario dove serviva, a fare smorfie di gioia o di dolore per aumentare la drammaticità dell’incontro, a ruggire come un leone pur essendo solamente un uomo.
Davanti a rumorose folle assiepate alla buona dentro a cortili di periferia, su palchi improvvisati in vecchie palestre che puzzavano di muffa e negli hangar di magazzini freddi e vuoti, Santo aveva fatto sognare la povera gente, saltando qua e là attorno all’avversario, il mantello giallissimo e la maschera rossa che lasciava scoperti la bocca e il mento, veloce e potente.
Sui muri della sua palestra, appesi a chiodi bui e arrugginiti, spiccavano i manifesti sbiaditi degli incontri più importanti che aveva tenuto in giro per il Sud America e
Marcos, inesorabilmente, si perse con devozione assoluta in quei colori stinti, promettendo a se stesso che sarebbe riuscito a fare altrettanto.
A quanto mi disse, infatti, gli divenne naturale dividere tra palestra e biblioteca il tempo che non passava a lavoro o con la mamma. Non provò alcuna fatica e non fece sforzi eccessivi: la sua anima e il suo fisico, uniti in un’alleanza indistruttibile, agirono trascinati da un entusiasmo inesauribile e sempre crescente.
Iniziò a scrivere timidi versi sul retro di qualche foglio di giornale ed in quelle
brevi, prime opere, imparò a lasciare respirare lo spirito, impratichendosi sempre più dell’arte di cantare la bellezza in ogni sua forma.
D’altro canto, con la scusa di festeggiare il carnevale, si fece cucire da sua madre una maschera azzurra che del suo viso rivelava solamente gli occhi e la bocca, un nuovo volto da indossare sul ring.
-Lavoravo e davo la maggior parte dei miei soldi alla mamma.- Mi disse una volta mentre vedevo che aveva voglia di parlare - La mia presenza la tranquillizzava e mi piaceva rimanere a chiacchierare con lei sulla vecchia veranda, seduti vicini uno all’altra sopra le sedie rotte, a guardare il sole scendere dietro il muro del cortile.
Lei continuava a chiamarmi Marcolito, anche se ormai ero grande e grosso. Penso mi vedesse ancora come un tempo, i calzoni corti legati con lo spago, i capelli spettinati e sporchi, le scarpe slacciate e impolverate.-
-Le facevi leggere le poesie che scrivevi?- Chiesi incuriosito.
-No, no…-
-Veramente?-
-Non le dissi mai nulla né delle poesie né della palestra. Non mi piaceva l’idea di farle vedere che stavo crescendo. Credo che iniziò così….-
E tacque.
-Iniziò cosa?- Chiesi sicuro che aveva davvero voglia di sentirsi fare quella domanda.
-La mia divisione.-
-La tua divisione?-
-Sì. Mi divisi in tre.-
-Scusa ma non capisco proprio.-
-Separai quello che facevo e creai tre vite differenti.-
-No, no, no. Non è chiaro per niente, Marcos. Scendi nei dettagli altrimenti non ci capisco un accidente.-
-Hai ragione, Telonious, hai ragione…. Diciamo che divisi me stesso in tre persone differenti: il lottatore, il poeta e il figlio di mia madre.-
-E… e perché?-
-Ah questo non lo so! Credo sia una specie di psicosi o roba del genere. Voglio dire… all’inizio non lo feci intenzionalmente ma poi credo che mi ci trovai bene. In fondo così le tre cose che amavo, e cioè mia madre, la poesia e la lotta, avevano ognuna una uguale parte di me, senza preferenze.-
-E’ incredibile.-
-Lo so.-
-E… e adesso?-
-Adesso cosa?-
-Adesso chi sei?-
-Adesso sono tornato Marcos.-
-E come mai?-
-Non so nemmeno questo. Forse perchè le mie tre vite separate sono andate a
compimento.-
-Come... a compimento?-
-Si sono… esaurite.-
-Come?-
-Hai davvero voglia di sapere tutto quanto?-
-Solo se tu hai davvero voglia di raccontarlo.-
-Come vuoi,- mi disse sorridendo- vorrà dire che d’ora in poi, quando non sapremo di cosa parlare , ti narrerò le gesta di Josaphat, El Caìn e Marcolito.-
-E chi sarebbero?-
-Le mie tre diverse personalità, appunto.- Rispose finendo quello che aveva nel bicchiere.- Il poeta, il lottatore e il figlio affezionato.-
-Avevano anche nomi diversi?-
-Sissignore, proprio così. Se vuoi capire tutta la faccenda devi tenere ben a mente questo: ad un certo punto smisi di esistere come Marcos e cominciai a vivere distribuendo il mio tempo e le mie energie in quelle tre parti distinte.-
-E’…è pazzesco.-
-Lo so.-
-Ma come facevi a starci dentro?-
-Come facevo a unire tutte e tre le cose?-
-Sì, cioè… voglio dire, come riuscivi a…-
-Ti stai chiedendo come ho incollato tre vite in una?-
-Esatto.-
-Non so di preciso, te l’ho detto. Vivevo la cosa in maniera totalmente dissociata. Credo che iniziai a trasformarmi spontaneamente in Marcolito quando passavo qualche ora con mia mamma e che piano piano anche El Caìn e Josaphat impararono ad affiancarsi a lui nella gestione della mia persona e dei miei interessi.-
-E tu non te ne accorgevi?-
-No, come avrei potuto? Mi dividevo e non conservavo alcun ricordo se non quelli della personalità che assumevo di volta in volta. Solamente non molto tempo fa, alla fine delle tre singole storie, riuscii a riassemblare tutti i pezzi e a fare un quadro di quanto era davvero accaduto.-
-Ci si potrebbe fare un film.-
-E’ un’idea.-
-Da quale dei tre vuoi cominciare a raccontare?-
-Non so… deciderò la prossima volta. Adesso devo andare dal reverendo Jacob. Devo sostituire un paio di tegole al tetto della chiesa anglicana.-
-Occhio a non cadere. Devi raccontarmi tutta la storia.-
-Que no se preocupe.-
Era appena uscito e già mi sentivo fremere dalla curiosità.
Come sono andate davvero le cose (01) testo di George Bailey