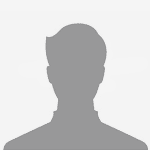‘Ti porto i ricordi che mi hai chiesto, te li porto domani, al solito posto’
‘Vedi di non dimenticarti nulla, come l’altra volta quando dimenticasti persino le parole…’
‘D’accordo. Ora ti saluto, vado a mangiare’
‘Di nuovo?’
Di nuovo, certamente, lo faccio appena posso, perché questa tavola imbandita mi stimola appetiti sempre nuovi. Passatemi il sale,
(è tutto sempre così insipido, ma non fatelo notare, l’aceto nasconde gli odori: lo usano per sgrassare i forni o per cancellare i disegni sporchi)
Verdure crude, bistecche alla griglia, petti di pollo in salsa rosa.
Ma nel mio piatto non c’è nulla. E’ dunque lecito supporre che non abbia fame.
Odori penetranti impregnano le giacche districate sugli appendini, e ogni tanto qualcuno si ricorda di spostarle, accendendo le finestre, aprendo le luci su questi disguidi primordiali.
(avvertimi quando la dislessia ti prenderà di nuovo, cadendo tra le note di una vecchia canzone folk)
Alla mia destra la donna che non ha un nome, ma un fascino da diva anni 50, mi rivolge la parola:
‘Il Suo volto non mi è nuovo, forse ci siamo già visti… Lei non è quel ragazzo che mi offriva delle rose per coprirmi i capelli, in modo che non apparissi più nuda di quanto sono?’
La donna è effettivamente nuda ma ha un ventre piatto e liscio:
‘Non mangia molto, vero? Dovrebbe provare questi gustosissimi involtini di panna e prosciutto abbrustoliti sulla fiamma viva, e vedrà come ogni cosa le apparirà dal lato giusto, esattamente come dovrebbe essere. Con un sano nutrimento a base di proteine e acidi distillati si accorgerà ben presto che ci siamo sempre visti, tutti i giorni da quando esiste la domenica, e che le rose non gliele ho offerte io. Odio le rose, le disprezzo in quanto portatrici di amori indesiderati, ma sono ottime per prepararsi tisane rilassanti quando non si sa come passare il tempo o quando fuori è troppo freddo per passeggiare nudi zigzagando tra i riflessi seminascosti della luna nel pozzo…’
‘Me la ricordo quella storia, risale a quand’ero bambina, quando si usava ritrovarsi tutti sotto lo stesso tetto a leggersi dei racconti a turno. Le è mai capitato di imprigionare la luna in un pozzo?’
Sollevo un dito verso il cielo, indicando qualcosa che probabilmente non c’è, e mentre le teste si sollevano simultaneamente come pupazzi a molla sorpresi da se stessi, lei si accorge dell’anello che non porto, simbolo sfavillante di una fede che non voglio.
Lo ammetto, la mia è stata solo una mossa astuta per portarle via il piatto.
‘Non è sposato?’
‘No. Sono solo fidanzato, ma è capitato per sbaglio, per noia, durante una di queste cene fasulle, tra l’antipasto di coni di riso ed un primo a base di pasta di mandorle amalgamata con dell’ottimo Bonarda dell’87, se non ricordo male. La cena era ottima, come sempre del resto, e colgo l’occasione per ringraziare la Contessa Deforme, sempre così aggraziata nello strisciare compostamente verso il suo trono di paglia e fango (o cuscini di plastica, a volte). Grazie per l’ospitalità, Contessa…”, sorrido chiudendo forzatamente un occhio, nel senso più fisico del termine. C’è una sorta di complice amicizia in questo gesto che ormai ripetiamo da tempo, molto tempo, e Lei sorride mentre solleva sgraziata il braccio, stringendo e artigliando un bicchiere di cristallo sporco, scheggiato in più punti, all’interno del quale, il Suo meraviglioso occhio di vetro mi fissa felice. Ammicca, poi ritorna immobile, sazio e impagabile, adagiato nel suo involucro immortale, accarezzato da spumante leggero, così frizzante da spargere bollicine di euforia tutt’intorno al salone, tra gli ospiti inebetiti dall’alcool.
Appoggio anch’io il mio bicchiere, e sempre sorridente mi volto verso la Dama senza nome, che nel frattempo ha cambiato pettinatura: non più lisci, lunghi e castani, ma intrappolati in due trecce bionde ai lati del viso che ne incorniciano la freschezza, la bellezza devastante che ogni volta estrae nuova purezza dal mio cuore arido.
“E’ molto carina oggi, sa…?” Lei sorride imbarazzata, e in un attimo svaniscono almeno altri 4 o 5 anni, disegnando un’adolescente intimidita nei suoi contorni evanescenti, “e anche quel Suo discorrere inutile sembra avere quasi un senso, oggi… potrei quasi chiederLe di sposarmi, per noia naturalmente… ma dica invece… Vuole farmi un pompino?’
La paranoia scivola nervosamente sulla sala. Due loschi disegnatori di ambulanze folk si consultano goffamente, interrogandosi l’un l’altro sul significato antropologico delle mie imbarazzanti parole.
“Squisitamente degradante” è il commento del Disegnatore n. 1, un buffo uomo sulla cinquantina, con i capelli bianchi e gli occhi incolori, la sua divisa da infermiere s’intonata melodicamente con il cappello da cuoco, e quell’espressione liscia, piatta, plastificata, utile per custodire asettiche constatazioni amichevoli durante incidenti mortali, è uno sfondo considerevole per quella voce, che sembra voler imitare il suono di una sirena, fastidiosa di notte come di giorno. Il suo camminare nervoso intorno alla tavola, in fondo, suona finto, fasullo come l’effetto Doppler che cerca di riprodurre attraversando velocemente il salone da una parte all’altra e poi ritorno.
Il Disegnatore n. 2 è un ragazzo che non parla, riduzione tascabile di una sciagura formato famiglia, abito scuro, pallore mortale a sottolinearne le innumerevoli vacanze al mare durante improbabili eclissi di luce e di vita, sedotto da ragazze da copertina, conigliette rosa felici di essere divorate da stupide tarme metropolitane incapaci di sentire rovi roventi svegliarlo di notte, gridandogli di alzarsi: “abbraccia il fucile e non fermarti mai”.
Il ragazzo si ferma: è chiamato spesso dalla folla a folli prove di stereotipata arguzia, utili per giustificarne il soprannome e così, anche oggi non delude, e disegna ambulanze con purè di patate, ketchup e puro caviale messicano.
Per lui le mie parole sono un’invidiabile caduta di stile, simbolo dell’uomo moderno, fagocitato da fobie infantili, derivanti da pessimi rapporti familiari con una figura paterna preponderante ed incombente; un odio spropositato verso tutto ciò che è stabilità, tranquillità e pace interiore.
Brindo enfaticamente alla sua dimostrabile intelligenza, ma lui la prende male. Mi guarda negli occhi, soffiandomi rabbia addosso, come fossero parole:
“l’unica tua speranza è la morte”.
Morte…?
Ma io ho chiesto solo un pompino! Sono depresso e offeso.
Mi volto verso la Dama, donna immaginaria ma perfettamente visibile nella sua fisicità, e ribadisco le mie umili, semplici, richieste.
Scandalizzata e sconvolta, Lei si alza, spostando per l’ultima volta lo sguardo verso quell’astro splendente che brilla al di la del soffitto e con un gesto di dignità estrema, calibrata nel dettaglio, mi mostra tutta la differenza che esiste tra uno come me, e Lei.
Nobiltà.
Si volta mostrandomi la schiena e tutto il resto, e questo suo essere nuda e vulnerabile in una sala adibita a sacro luogo di nutrimento per il corpo, mi mette a disagio.
Però è molto bella.
(Apparentemente siamo entrambi esseri umani)
Purtroppo se n’è andata. Purtroppo l’ho delusa. Finalmente posso mangiare.
Ho davanti a me il suo piatto, sfiorato dalle sue dita lunghe e delicate.
Ed è vuoto.
Inutile dire che qua c’è qualcuno che ruba. Non so di chi sospettare ma sono certo di una cosa: io non ho mangiato. Guardo gli altri commensali scrutandoli uno per uno e sono così tanti che l’operazione richiede diversi giorni. Quattro per l’esattezza.
Al quinto giorno ci ritroviamo tutti, allo stesso posto, le stesse facce e gli stessi vecchi vestiti che non potremmo mai cambiarci per rispetto dei nostri ricordi e di quelli che ancora aspettano di rimanere impressi tra le membrane adipose dei nostri pensieri.
La malattia non mi permette di assorbire i lineamenti e le caratteristiche facciali delle persone che incontro. Non riconosco gli uomini, e neanche le donne, ma a volte la differenza è minima. Quindi sono giustificato.
La donna alla mia destra non è tornata e non è così strano visto che oramai sarà sazia, pur non avendo assaggiato nulla di tutto questo ben di Dio. C’è tutto, questa volta.
Tutto come l’avevo lasciato. Le portate sono le stesse, le pietanze stanno marcendo e c’è chi sta male e c’è chi vorrebbe abbandonare la cena, rinunciando a tutto ciò che gli spetta. Ma nessuno si muove. Siamo legati dallo stesso destino di persone affamate che non trovano ciò che le sazierà per un tempo illimitato: un infinito che ritorna dal passato e si proietta nel presente, lasciandosi dietro briciole di spasmodiche emozioni che qualcuno riassorbirà. Inghiottendole.
LA LUNGA CENA MARCIA testo di Lythium